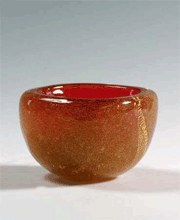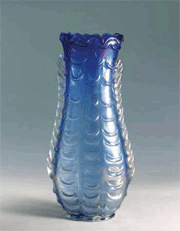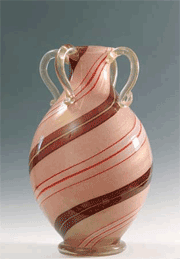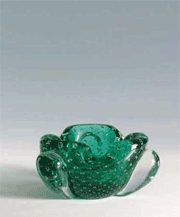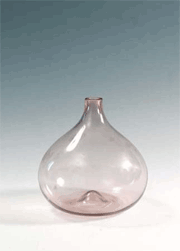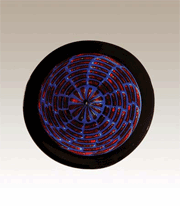Venezia
Vetrai, a Venezia, sono menzionati sin dal X secolo ma sembra che la produzione non conosca grande sviluppo che a partire dal Duecento, quando verosimilmente si creò la corporazione dei vetrai che, dal 1292, si trasferiscono nella vicina isola di Murano. È solo nel ‘400 però che si può dare una attribuzione incontestabile ad oggetti di questa provenienza: sono, in genere, vetri di colore scuro decorati a smalto, o vetri a filigrana, o vetri bianco latte (lattimo), probabilmente ispirati a quelle porcellane cinesi che dogi e ottimati ricevevano in dono dai sovrani orientali.
Nel ‘500 non ha più misteri l’antica tecnica del millefiori, ma neppure il vetro calcedonio o l’avventurina o il vetro incolore, che ben si adatta al gusto del Rinascimento, chiamato cristallo e ottenuto usando il manganese come decolorante. Non si conosce il nome del suo inventore né quello di chi lo perfezionò, ma si pensa che Angelo Barovier (morto nel 1460), membro di una delle più famose famiglie di vetrai, abbia avuto un ruolo importante in questa sperimentazione. Insieme alle nuove tecniche anche le forme subiscono una notevole evoluzione e diventano sempre più complesse e ricercate, tanto che ormai il vetro alla veneziana è ovunque rinomato e i suoi maestri richiesti in tutta Europa. Al fine di preservare e migliorare la qualità della produzione, le autorità veneziane controllavano l’importazione delle materie prime, anche a scapito di un aumento dei costi finali. Tra questi materiali c’era anche un’alga delle paludi salmastre, la barilla, da cui si ricavava la cenere di soda, componente fondamentale per ottenere quel sottile vetro incolore che assicurava all’industria vetraria di Venezia la supremazia su tutte le altre.
Il ‘700 è il secolo della crisi che investe globalmente la vita di questo stato che fino ad allora aveva dominato sul piano storico, politico ed anche economico: nel settore del vetro, ad esempio, dei tremila artigiani vetrai che Murano contava alla fine del ‘500, non ne restano che 383. Da una parte ciò si deve far risalire alla concorrenza europea, in particolare alla Boemia che, con l’eccellente qualità del suo vetro finissimo, con le rinnovate tecniche di lavorazione (l’intaglio e l’incisione) e i prezzi modici, riesce ad avere il sopravvento. Così i ruoli si invertono: sono i commercianti veneziani a chiedere il vetro ad uso Boemia ed i vetrai a cominciarne la produzione, primo fra tutti nel 1737 quel Giuseppe Briati che, fra l’altro, con il suo estro artistico riconducibile all’epoca barocca, crea il famoso lampadario veneziano, incolore o colorato, forgiato a forno e decorato di fiori e foglie dalle tinte sgargianti. Ma non bisogna dimenticare che le ragioni della decadenza sono ben più profonde: nel 1797 cade la Repubblica, nel 1806 viene annessa al napoleonico Regno d’Italia, nel 1814 inizia la dominazione austriaca. È chiaro che tutto ciò sconvolge ulteriormente una situazione già di crisi, e lo scioglimento nel 1806 delle corporazioni dei vetrai, che fino ad allora aveva in qualche modo regolamentato l’arte, accentua le difficoltà.
Eppure tutta questa tempesta sembra aver soltanto assopito la capacità di spirito e di indipendenza, ché gli anni intorno al 1840 vedono numerosi segnali di rinascita legati anche ad un processo di imitazione dei prodotti dei secoli passati. E così cominciano a sorgere nuove moderne vetrerie come, nel 1854, quella dei Fratelli Toso e nel 1859 quella di Antonio Salviati, la cui produzione riscuote un grande successo alle Esposizioni Internazionali di Londra e di Parigi nel 1862 e 1864, tanto da convincerlo ad aprire una sua succursale a Londra nel 1868. Come si è accennato, dunque, il criterio informativo di questo periodo è da ricondurre allo studio minuzioso dei capolavori dell’antica vetreria romana e di quella muranese dal Quattrocento in poi, affinando così l’abilità tecnica e il gusto e dando respiro alla creatività. Quindi, mentre nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti si era verificata la rottura con il passato avviando una produzione di tipo moderno, Murano resta legata alla tradizione.
Solo nei primi decenni del Novecento appaiono evidenti segni di rinnovamento ispirati alla semplificazione formale suggerita dal Funzionalismo. Così, i primi vetri della storica fabbrica Cappellin, Venini & C., fondata nel 1921 da Cappellin e Venini con la direzione artistica di Vittorio Zecchin, sono caratterizzati da una grande semplicità memore dei leggerissimi soffiati di epoca rinascimentale. Da questo momento è tutto un nascere, affermarsi, decadere, fallire o risorgere di diverse vetrerie che, particolarmente numerose, hanno contrassegnato il secolo. Una storia fatta dai maestri vetrai, ma anche dai proprietari delle fornaci e, soprattutto, dagli artisti che molta parte hanno avuto, ed hanno tuttora, nella riqualificazione della produzione vetraria. Come si è già fatto cenno altre volte in questo panorama della storia del vetro, è stata la necessità di adeguarsi alla cultura figurativa contemporanea, anche per esigenze di mercato, a vedere, nel Novecento, il coinvolgimento di artisti e professionisti esterni che riuscissero a trasferire, in un mondo come quello del vetro che rischiava di chiudersi troppo nella tradizione, le tensioni innovative del proprio tempo, favorendone l’apertura verso le arti maggiori.
Fratelli Toso
Fondata nel 1854 da sei fratelli Toso, produce inizialmente vetri per uso domestico e flaconi farmaceutici, oltre che copie di vetri antichi. A periodi che vedono una produzione ispirata alla tradizione, ne alterna altri di notevole modernità come nel 1912 e 1914, quando si presenta alla Biennale di Venezia con opere dell’artista norvegese Hans Stoltberg Lerche che ottiene un notevole successo, nel 1936, quando Ermanno Toso ne assume la direzione artistica, o negli anni Sessanta e Settanta con le opere di Renato, Giusto e Rosanna Toso. Cessa l’attività nel 1982.
|
|
M.V.M. Cappellin & C.
Nel 1921 era nata, dall’incontro dell’antiquario veneziano Giacomo Cappellin con l’avvocato milanese Paolo Venini, la Cappellin Venini & C., sotto la direzione artistica di Vittorio Zecchin, pittore muranese e artista dalle varie sfaccettature, che, memore dei modelli rinascimentali, creava oggetti dalle forme essenziali in sottile vetro soffiato trasparente, colorato delicatamente in paglierino, azzurro, verdino o violetto. Già nel 1925, però, Cappellin e Venini si separano dando luogo a due diverse società, la M.V.M. Cappellin & C. e la V.S.M. Venini & C.
Con Cappellin rimane dunque Vittorio Zecchin, ma solo fino al 1926, quando viene sostituito dal giovane architetto Carlo Scarpa che, in un primo tempo, prosegue la linea artistica già impostata da Zecchin, ma successivamente ne propone una sua fatta di sottili vetri in pasta vitrea dalle accese colorazioni, vetri lattimi a foglia d’oro o d’argento, vetri a canne verticali e a millefiori.
Ma già nel 1932, per dissesti finanziari, Cappellin deve chiudere e Carlo Scarpa passa alla V.S.M. di Venini.
Venini & C.
La storia delle vetrerie veneziane è, come si è già detto, una storia tormentata da continue divisioni e trasmigrazioni di artisti e maestri dall’una all’altra, ma tutto ciò alla fine assume una valenza positiva in quanto viene a crearsi un reticolo di esperienze comuni, una somma di conoscenze che conferisce al vetro di Murano una fisionomia del tutto particolare e immediatamente distinguibile nel panorama europeo ed anche internazionale.
Così succede anche per la Venini & C. che trae le sue origini dalla V.S.M. Venini & C., la quale, a sua volta, era sorta nel 1925 dalle ceneri della Cappellin Venini & C., con la guida di Venini e la direzione artistica dello scultore novecentista Napoleone Martinuzzi; quando nel 1932 Martinuzzi esce per fondare una sua manifattura si costituisce appunto la Venini & C. che si avvale della collaborazione di Carlo Scarpa che, entrato nel 1931, rimarrà fino al 1947, continuando la ricerca già iniziata alla M.V.M. Gli anni fra il 1931 e il 1936 sono i più fecondi per Scarpa: appaiono i vasi in filigrana, in vetro sommerso e in vetro opalino, ma anche il vetro pesante e non trasparente, o leggerissimo ma a due strati, poi il vetro tessuto e la personalissima reinterpretazione del vetro murrino che va a formare la trama, spessa ed opaca, abitualmente nera o rosso corallo, di grandi ciotole. Il 1940 è l’anno della grande affermazione alla XXII Biennale di Venezia e alla VII Triennale di Milano.
Nel secondo dopoguerra la Venini & C. continua sulla linea di utilizzare l’esperienza e le conoscenze specifiche di artisti e designers di grande livello come Giò Ponti, Tyra Lundgrem, Tapio Wirkkala, Tobia Scarpa e in particolare Fulvio Bianconi che contribuisce in maniera rilevante alla nuova impostazione stilistica della vetreria. E non va dimenticata neppure l’opera di supervisione di Paolo Venini, che è stato sempre accanto ai suoi collaboratori nella realizzazione delle opere, fino alla sua morte nel 1959.
A questo punto la direzione passa al genero Ludovico Diaz de Santillana fino al 1986, quando lascia la conduzione dell’azienda cedendo le sue quote azionarie al gruppo Ferruzzi; nel 1998 infine la vetreria entrerà a far parte del gruppo finanziario Royal Scandinavian.
|
|
|
|
Barovier & Toso
È questo il nome attuale di quella manifattura che, pur sembrando operante dal 1878, nasce nel 1884 con Giovanni Barovier insieme ai nipoti Giuseppe, Benvenuto e Benedetto, assumendo il nome di Artisti Barovier e affermandosi ben presto per la raffinatezza di una produzione che tentava di svecchiarsi rompendo in qualche modo i legami con il passato. Per questo è alla Ca’ Pesaro, e non alle Esposizioni Biennali Internazionali d’Arte dove partecipava l’arte ufficiale, che compariranno i loro vetri murrini, fra le cose più belle uscite dalla loro fornace.
Nel 1919, con l’entrata nella società di Ercole e Nicolò, figli di Benvenuto, e Napoleone, figlio di Giuseppe, diviene Vetreria Artistica Barovier & C. Si dimostra subito fondamentale l’apporto di Ercole come direttore artistico e instancabile ideatore di nuovi modelli e tecniche: a lui si deve, infatti, l’introduzione a Murano del vetro spesso e pesante, già in uso in Francia, ma ancora guardato con diffidenza nell’isola. Nascono così i vetri primavera in un materiale bianco finemente retinato accostato al nero lucente dei fili che delimitano gli orli e formano le anse; i vetri crepuscolo o gemmati, nel 1935-36, che costituiscono le prime prove della tecnica della colorazione a caldo senza fusione, e i rostrati del 1938, dagli effetti di brillante sfaccettato.
|
|
Nel 1936, separatosi dal fratello Nicolò, Ercole si associa alla SAIAR Ferro Toso costituendo la Ferro Toso e Barovier, che nel 1939 diventerà Barovier Toso & C. e nel 1942 Barovier & Toso, fino ad oggi. Nel dopoguerra Ercole si dedica prevalentemente a nuove sperimentazioni sul colore, producendo vetri a tessere dai colori molto vivaci, e alla rielaborazione di antiche tecniche come quelle del vetro a murrine, con la serie, negli anni ’60 e ’70, dei dorici, dei caccia, dei rotellati. Nel 1951, quando espone le sue opere all’Angelicum di Milano, la critica premia il suo impegno riconoscendogli “una fertilità e un’abilità creativa tali da doverlo annoverare fra i nostri migliori vetrai viventi”. Muore nel 1974 e nella conduzione dell’azienda gli succede il figlio Angelo che, sulla linea dell’uso invalso a Murano nel Novecento, si avvale della collaborazione di numerosi artisti, lui stesso, d’altra parte, designer e pittore che aveva già partecipato a varie esposizioni in Italia ed all’estero.
Seguso Vetri d’Arte
Nata nel 1933 da Archimede, Ernesto e Alberto Seguso insieme ad alcuni maestri che si erano staccati dalla Vetreria Artistica Barovier, nel ’34 assume alla direzione artistica Flavio Poli che, con la riorganizzazione della società nel 1937, ne diviene anche socio. Ed è proprio Flavio Poli la vera anima di questa vetreria con i suoi animali in vetro pesante dalle tinte delicate o in cristallo molato, le sue valve in vetro sommerso o i vasi in vetro bulicante. Si ritira nel 1963 ma la produzione continua ad avere la sua impronta.
|
|
Nason & C.
Ermanno Nason nasce a Murano nel 1928 da una delle più antiche famiglie dell’isola, i cui ricordi affondano nei secoli, sino al ‘300. Da sempre in casa si respirava vetro: lo lavoravano il nonno, il padre, gli zii, i fratelli, tutti maestri sia nel disegno che nella realizzazione. Anche lui, fin da piccolo va in fornace e contemporaneamente frequenta la scuola per vetrai guidata da Vittorio Zecchin; diventa Maestro a diciotto anni lavorando per la A.Ve.M. e per la Ferro-Toso. Dal 1953 fino al 1958 collabora con la I.V.R. Mazzera, nel 1959 fonda la Arte Nason & C. che rimane attiva fino al 1963, dal 1964 al 1972 lavora con Gino Cenedese. Ma Nason è innanzi tutto uno spirito libero, perciò lavora anche autonomamente e non interrompe mai i rapporti con altre vetrerie come la Fucina degli Angeli realizzando, da grande maestro, quale è stato, opere di grandi artisti come Pablo Picasso, Marc Chagall, Jean Cocteau.
|
|
Effetre International
Fondata nel 1976 da Guido, Mario e Ivano Ferro, la vetreria ha impiegato grandi risorse nella ricerca sul colore e sulle tecniche, grazie anche alla presenza di Lino Tagliapietra che, dopo l’apprendistato nelle fornaci muranesi, l’attività di maestro nella vetreria di Galliano Ferro, e le varie collaborazioni con le vetrerie Venini e La Murrina, entra fin dalla sua costituzione alla Effetre con il ruolo di direttore artistico; oggi è uno dei più apprezzati artisti del vetro contemporaneo.
|
|